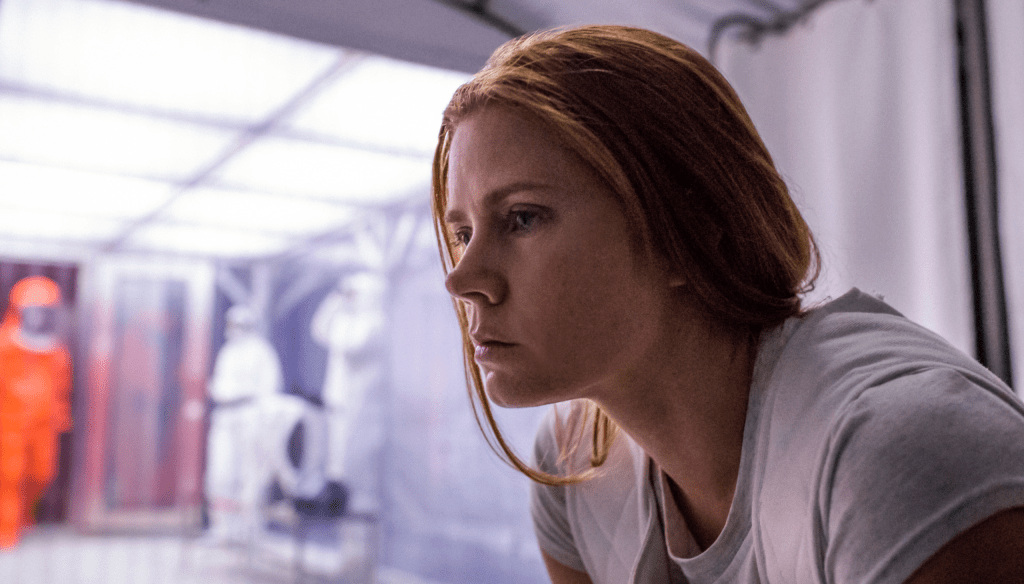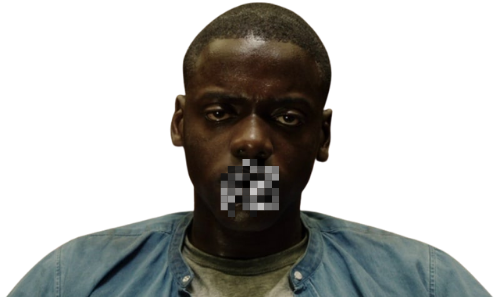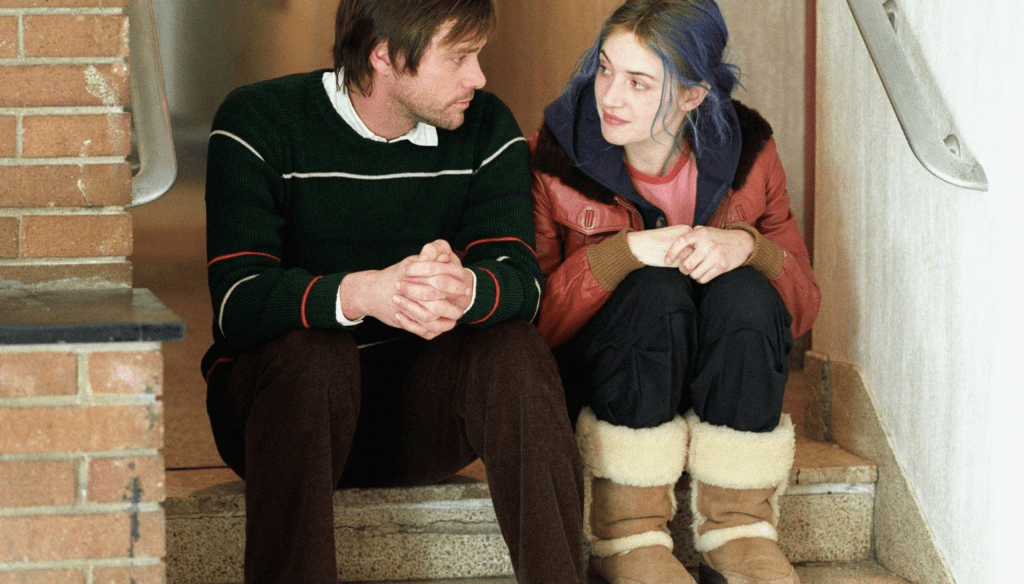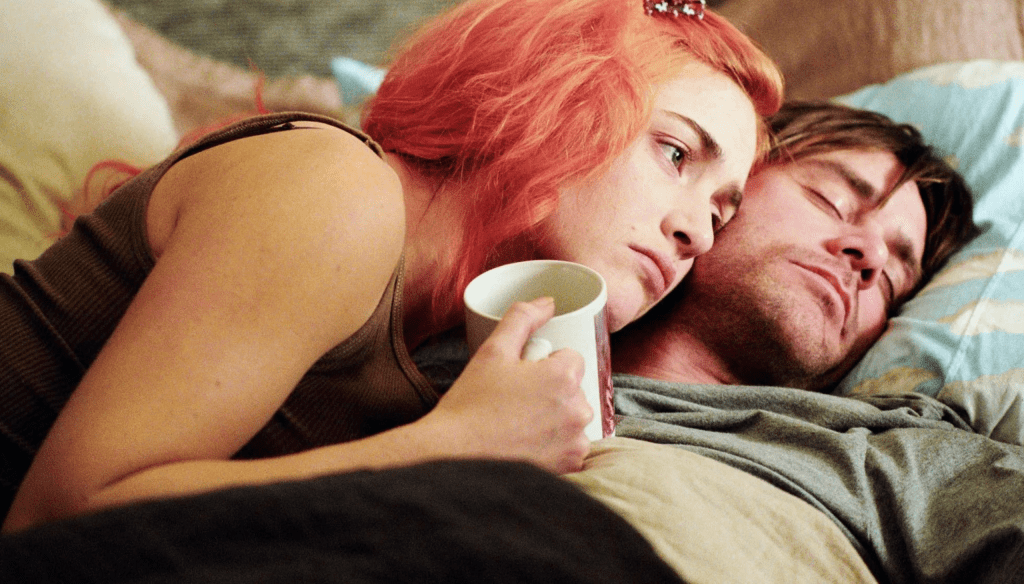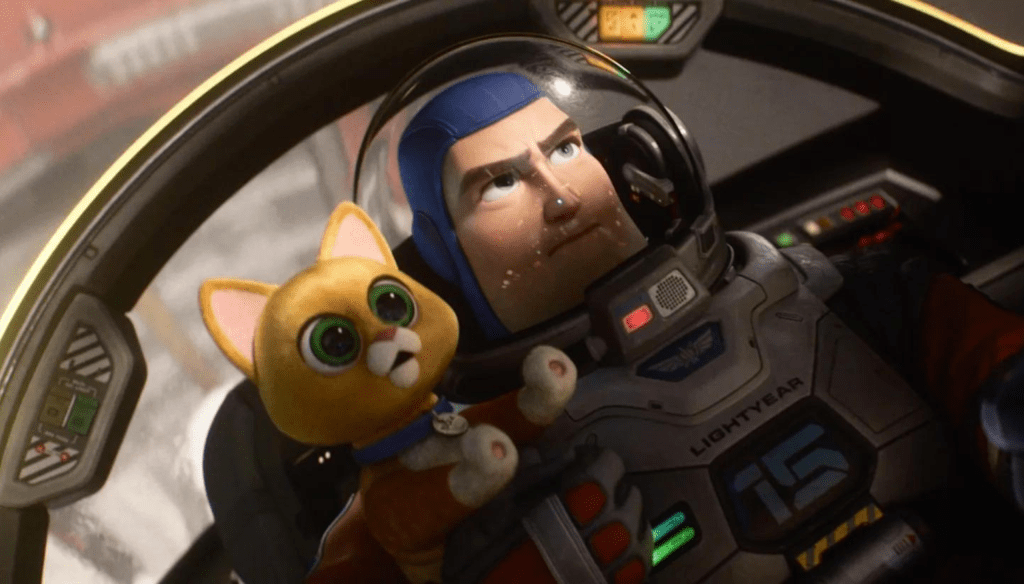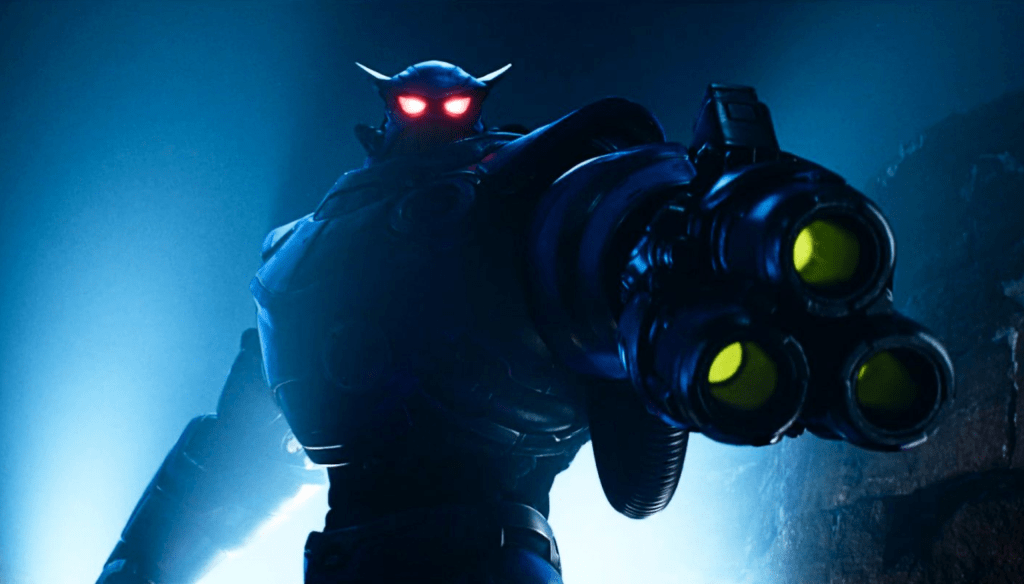First man (2018) di Damien Chazelle è il terzo lungometraggio del regista famoso per La La Land (2016).
Purtroppo questo nuovo progetto non ebbe per nulla lo stesso riscontro, anzi fu sostanzialmente ignorato al di fuori del circuito dei festival.
E fatti fu un flop commerciale: appena 105 milioni di dollari di incasso contro un budget di 59.
Di cosa parla First man
1962, Stati Uniti. Dopo un importante lutto familiare, Neil Armstrong, il primo uomo che metterà piede sulla Luna, entra a far parte del progetto Gemini della NASA e la sua corsa disperata verso lo spazio.
Un viaggio per nulla semplice, e molto meno glorioso di quello che si potrebbe pensare…
Vi lascio il trailer per farvi un’idea:
Perchè First man è stato un flop e perché guardarlo comunque

Dipende.
Il flop di First man è facilmente spiegabile: Chazelle, invece che piegarsi al successo di La La Land, ha deciso di sperimentare con un genere diverso.
E ha prodotto una pellicola sublime, con una tecnica registica di altissimo livello, ma decisamente molto meno spendibile per il grande pubblico. Il film è infatti drammaticamente lento, ma con una lentezza voluta e necessaria.
E infatti va visto con calma, prendendosi il suo stesso tempo. E va vista perché è una pellicola spettacolare, con una tecnica e una scrittura che si avvicina a certi capolavori di Lars von Trier. Non a caso a me ha ricordato per certi aspetti Melanchonia (2011).
Quindi prendetevi il vostro tempo, ma guardatelo.

Storia di un fallimento

Soprattutto se non si fa parte della generazione che visse il periodo, è difficile immaginarsi il clima che circondò l’Allunaggio.
In piena guerra fredda, con questa isteria collettiva di contrasto alla Russia che si vede anche ne Il gigante di ferro (1999), e davanti ad una scia di morti e fallimenti che guastarono la credibilità del progetto. E, di conseguenza, un generale malumore dell’opinione pubblica.
Perché effettivamente per l’uomo comune statunitense esplorare lo spazio non era una grande scommessa.
E non lo è neanche per i contemporanei: basta solo pensare che gli astronauti che esploreranno altri pianeti oltre la Luna non sono, con ogni probabilità, ancora nati. E chissà quante generazioni passeranno prima che potremo vivere oltre la Terra o almeno sfruttare le risorse che gli altri pianeti ci offrono.
Fatte queste premesse, è più facile immedesimarsi nel sentimento popolare del tempo.
L’uomo sulla luna

Il racconto di Neil Armstrong è drammatico ma necessario: non un eroe, ma un uomo come tanti, con una situazione familiare complessa, e, soprattutto, un uomo assolutamente fallibile.
Si evita insomma un tipo di narrazione di predestinazione, come si può vedere in film molto più commerciali come Captain America (2011). L’unico elemento di predestinazione in qualche misura è il fatto che il protagonista guarda sempre verso la Luna.
Ma perché Luna è un luogo lontano, quasi rassicurante, dove per un attimo Neil può davvero distaccarsi dai suoi problemi terreni, dove può finalmente dirgli addio. Toccante la scena in cui si lascia scivolare dalle dita il braccialetto della figlia, di cui non aveva mai più parlato, ma la cui morte l’aveva profondamente turbato per quasi dieci anni.
E infine si riconcilia con la moglie, che accetta la sua mano tesa.
Una regia perfetta

Quando parlo di una regia perfetta non credo di esagerare: non poteva esserci una tecnica migliore di questa per raccontare questo tipo di storia. Chazelle fa infatti grande uso della camera a mano, dando un taglio molto intimo alla maggior parte delle scene.
E, con il suo continuo e sublime uso dei primi piani stretti e strettissimi, il suo indugiare sui particolari, fa sentire lo spettatore come se fosse veramente in quella stanza, in quella astronave, ad osservare la scena.
Ancora più splendida la scelta della rappresentazione dello sbarco: sulla Luna non ci sono rumori e, quando si incammina, Armstrong non può sentire nient’altro che se stesso, il proprio respiro affannoso.
E, così, avere un momento di pace.